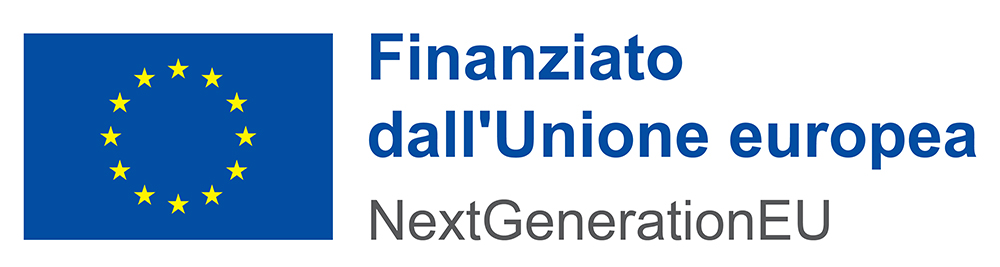Matraini Chiara

Varianti del nome
Chiara Matraini Contarini, Chiara Contarini Matraini, Chiara Cantarini de Matraini, Chiara Matraini Cantarini
Data di nascita
4 giugno 1515
Luogo di nascita
Lucca
Data di morte
Novembre 1604
Luogo di morte
Lucca
Breve biografia
Nasce a Lucca il 4 giugno 1515, da Benedetto Matraini e Agata (o Agnese) Serantoni. La famiglia Matraini è una famiglia di tessitori, originaria del borgo di Matraia, che assume prestigio a seguito del suo trasferimento a Lucca, avvenuto intorno alla metà del XIV secolo. Perde il padre l’anno successivo la sua nascita e viene affidata allo zio paterno Rodolfo.
I Matraini si inseriscono prepotentemente nelle vicende politiche dell’epoca: quando lo zio Rodolfo viene eletto nel Consiglio cittadino, il 4 maggio 1531, l’intera famiglia era già stata compromessa dall’allontanamento definitivo del fratello di Chiara Matraini, Luiso, dalle cariche pubbliche, causa l’accusa di sodomia gravante sulla sua persona. Luiso, Rodolfo ed un altro parente, Lorenzo Matraini, sono protagonisti del moto degli straccioni del 1531, volto al sovvertimento del sistema oligarchico della Repubblica lucchese, con il proposito di consentire l’accesso a cariche pubbliche anche a componenti della piccola nobiltà e della media borghesia. La repressione è durissima e il fallimento del moto ha conseguenze incontrovertibili sulla famiglia di Matraini e, pertanto, anche sulla storia personale della poetessa: Luiso viene incarcerato e muore in prigione, nel 1535; viene incarcerato anche un certo Filippo Matraini, che, dopo la sua evasione, viene condannato all’esilio da Lucca e a morte in contumacia; Lodovico viene decapitato, con conseguente confisca dei beni, nel 1532; Rodolfo si ritira a vita privata (Rabitti, 2008).
Il 15 maggio 1531 Chiara Matraini viene data in sposa a Vincenzo Cantarini, al quale era stata promessa, con versamento di una dote di 300 scudi, già nel 1530. Il legame con un’altra cerchia familiare, anche se antecedente ai fatti dei moti, non attenua l’impatto negativo sul cognome della donna. I Matraini, tintori e tessitori, e i Cantarini, filatori e pellicciai, sono stati entrambi fautori del suddetto moto del ‘31, tuttavia, nel 1532, le due famiglie si ritrovano a essere avversarie, causa una delazione da parte di alcuni esponenti dei Cantarini (Ortu, 2014).
In questo contesto non privo di asperità Matraini mette al mondo Federigo, battezzato il primo marzo del 1533. Si perdono, poi, notizie della donna almeno fino all’inizio degli anni Quaranta.
Nel 1542 vive la perdita del marito e si inserisce nella dimensione politica, allontanandosi dalla vita familiare. Intorno al 1547 si ha già notizia della passione tra Matraini, nota a quest’altezza cronologica come poetessa e musicista (Nerici, 1880), e Bartolomeo Graziani, genero di Gherardo Sergiusti. La poetessa avrebbe avuto una relazione adulterina con Graziani, che viene assassinato, poi, in circostanze poco chiare, certamente prima del 1555, anno in cui viene pubblicato il primo canzoniere della Matraini all’interno del quale la poetessa allude proprio alla morte violenta dell’amato (Acucella, 2018). La poesia di Chiara Matraini attesta un’esperienza di vita assolutamente distante da quella canonizzata delle poetesse della sua epoca; il corpus delle sue poesie ottiene un certo riconoscimento, anche se non considerato tra le opere fondamentali dell’epoca. Nel 1556 la poetessa è autrice del volgarizzamento dell’orazione pseudoisocratea A Demonico.
Negli anni Cinquanta, inoltre, Matraini frequenta un biasimato salotto letterario, che, secondo la ricostruzione fatta da B. Baroni in Vita di Gherardo Sergiusti, sarebbe stato fondato proprio dall’amante di Matraini, Graziani.
Matraini entra nella dimensione letteraria e politica di Lucca, ambiente che risente fortemente dei fermenti eterodossi fondati sulla circolazione di idee della Riforma, aderenti e contigue alle istanze spirituali di ascendenza erasmiana e valdesiana. Tra i letterati e tipografi con i quali entra in contatto importante è il sodalizio con Lodovico Dolce e Ludovico Domenichi, che aiutano Matraini nel suo progetto di autopromozione: Dolce inserisce il canzoniere matrainiano nel settimo tomo della raccolta antologica Rime dei signori napolitani, e d’altri (Giolito e fratelli, 1556) e Ludovico Domenichi raccoglie alcune composizioni dello stesso nel suo Delle rime di diversi eccellentissimi autori (Busdraghi, 1556). Il fatto che le sue poesie fossero già state pubblicate in una raccolta personale potrebbe aver portato Domenichi alla considerazione pratica di escludere Matraini dall’antologia delle poetesse italiane Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne, edita nel 1559 (Lorenzi, 1997). Altra plausibile interpretazione per tale omissione potrebbe essere, altrimenti, un’incrinatura nel rapporto tra i due.
Intorno al 1560 Matraini avrebbe incontrato Cesare Coccapani, legato alla famiglia estense e auditore di Rota a Lucca: nasce, tra i due, un profondo sodalizio spirituale e intellettuale, nonché un presunto amore, successivo alla morte del Graziani (Acucella, 2018). Tra il 1562 e il 1565, a Genova, Coppacani si occupa della disputa giudiziaria in merito alla dote nuziale di Chiara, che Federigo non voleva restituire alla madre. Fino al 1576 si perdono nuovamente tracce della poetessa, finchè, proprio in quell’anno, non commissiona ad Alessandro Ardenti un quadro, La Sibilla cumana, concluso da Cellini e pensato per decorare la sua sepoltura nella cappella di Santa Maria Forisportam a Lucca. Tra il 1581 e il 1590 vedono la luce opere d’ispirazione contenutistica spirituale; per i tipi di Vincenzo Busdraghi vengono, infatti, stampate: Meditazioni spirituali (1581), Considerazioni sopra i sette salmi penitenziali del gran re, e profeta David (1586) e il Breve discorso sopra la vita e laude della Beatiss. Verg. e Madre del Figliuol di Dio (1590), che andò incontro a una maggior fortuna rispetto alle altre due. A questa altezza cronologica avviene anche la stesura dei Dialoghi Spirituali, editi, però, solo nel 1602. Matraini torna, dunque, a dedicarsi alla lirica e, a distanza di quarant’anni dalla prima edizione a stampa (siglata A), fa pubblicare, nel 1595, le Lettere della Signora Chiara Matraini, gentildonna luchese, con la prima e la seconda parte delle sue Rime (edizione siglata B), cui seguono, nel 1597, le Lettere di madonna Chiara Matraini, gentildonna lucchese, con la prima e seconda parte delle sue Rime. Con una lettera in difesa delle Lettere e delle Arme (siglata C). Il periodo di grande dedizione nei confronti della produzione letteraria di ispirazione religiosa e meditativa influisce sul ritorno di Matraini ad una scrittura profana, che sarebbe avvenuto proprio attraverso la riedizione del canzoniere. Il libro di rime matura accanto alla maturata consapevolezza spirituale della poetessa, pur mantenendo echi della originaria impostazione. Dopo aver fatto testamento per la quarta volta, Chiara muore nel 1604 e viene sepolta il 9 novembre nella tomba di Santa Maria Forisportam, come da sua volontà (Ortu, 2014).
Totale componimenti disponibili - Tipologia e metro
199, di cui 171 sonetti, 7 canzoni, 13 madrigali, 5 ottave, 1 ballata, 2 sestine
Sonetti
171
Canzoni
7
Madrigali
13
Ballate
1
Sestine
2
Manoscritti
Lucca, Biblioteca statale di Lucca, 1547 [Lettere e poesie del sig. Cesare Coccapani auditore di Lucca e di donna incerta lucchese]
Lucca, Biblioteca statale di Lucca, 926 (BB.4R), ff. 137r-137v
Edizioni di Rime
Matraini, 1595 Matraini, 1597 [77 son., 3 canz., 3 madr., 3 ott.]
Edizioni moderne di Rime
Rabitti, 1989 [sezione A: 83 son., 6 canz., 5 madr., 3 ott., 2 sest,]
[sezione B: 65 son., 3 canz., 6 madr., 3 ott.]
[sezione C: 77 son., 4 canz., 4 madr., 2 ott.] Maclachlan-Rabitti, 2008: 40-101 [35 son., 4 canz., 4 madr., 1 ott., 2 sest.]
Cox, 2013: 108-114, 148-150, 240-242, 335 [10 son., 1 madr., 1 sest.]
Acucella, 2018b [94 son., 3 canz., 8 madr., 3 ott., 1 ball.]
Presenza in antologia
Dolce, 1556: 68-154 [89 son., 6 canz., 5 madr., 3 ott., 2 sest.]
Bergalli, 1726: 167-176 [10 son., 1 canz., 1 madr.]
Crescimbeni, 1730: 142-143 [1 son.]
Fiori di rimatrici italiane,1846: 24-26 [1 son., 1 ball.]
Baldacci, 1975: 383-409 [33 son., 3 madr., 1 ball., 1 sest.]
Ferroni, 1990: 244-248 [6 son.]
Lorenzi, 1997: 87-153 [10 son.]
Russell, 2000: 415-427 [2 son., 1 madr.]
Ortu, 2014: 129-169 [11 son., 3 madr.]
Desideri, 2018: 92-99 [2 son.]
Presenza in edizioni di opere di altri autori
Quanto l’alta Colonna il suo gran Sole Rabitti, 1985; Cox, 2013: 150; Acucella 2017: 8
Altre opere
Traduzione dell’Oratione d’Isocrate a Demonico figliuolo d’Ipponico [1556]
Carteggio Matraini-Coccapani [1560]
Meditationi spirituali [1581]
Considerazioni sopra i Sette Salmi Penitentiali del gran re e Profeta Davit [1586]
Breve discorso sopra la vita e laude della beatissima vergine e madre del figliuol di Dio [1590]
Dialoghi Spirituali [1602]
Edizioni di altre opere
Traduzione dell’Oratione d’Isocrate a Demonico figliuolo d’Ipponico
Matraini, 1556 Meditationi spirituali
Matraini, 1581 Considerazioni sopra i Sette Salmi Penitentiali del gran re e Profeta Davit
Matraini, 1586 Breve discorso sopra la vita e laude della beatissima vergine e madre del figliuol di Dio
Matraini, s.a. Dialoghi spirituali
Edizioni moderne di altre opere
Carteggio Matraini-Coccapani
Iconografia
1 ritratto [Matraini, 1555: frontespizio]
2 ritratti [Matraini, 1586: f. III v, f. IV v]
1 ritratto [A. Ardenti e F. Cellini, La sibilla cumana predice a Cesare la venuta del salvatore, 1576, olio su tela, Lucca, Museo nazionale di Villa Guinigi, 441] (Trenta, 1820; Paoli, 2008; Rabitti, 2008; Acucella, 2018b; Stella, 2024)
Studi
Acucella, 2017: 1-9; Acucella, 2018a: 743-768; Acucella, 2018b; Baldacci, 1953: 53-67; Baldacci, 1957; Baldacci, 1975: 383-409; Bosio-Nacci, 2017; Bosio, 2019: 1327-1335; Bullock-Palange, 1980: 235-262; Cajelli, 2019: 229-250; Carapezza, 2017: 129-149; Carinci, 2017: 145-160; Carlson, 2011: 439-458; Clarà-Segarra-Torrent, 2011: 231-233; Cox, 2008; Cox, 2011; Cox, 2013: 108-114, 148-150, 240-242, 335; Desideri, 2018: 92-99; Endicott, 2010: 1261-1262; Frank, 2010: 643-645; Lorenzi, 1997: 87-153; Maclachlan-Rabitti, 2008; Marcheschi, 2008; Mario, 2020: 191-197; Milligan, 2018; Monti, 2022; Moody, 2001: 632-636; Nerici, 1880: 325, 344; Ortu, 2014: 129-169; Panizza, 2017; Paoli, 2003: 521-545; Paoli, 2008: 7-20; Pietrobon, 2021: 103-109; Rabitti, 1981: 141-165; Rabitti, 1983: 110-145; Rabitti, 1985: 225-250; Rabitti, 1994: 243-252; Rabitti, 1999: 209-234; Rabitti, 2008: 128-131; Robin, 2007: 200, 202, 203, 206, 214, 235, 236, 252, 258, 264, 327, 329, 356; Russell, 2000: 415-427; Stella, 2024: 25-40; Tiraboschi, 1833: 154; Trenta, 1820: 79; Wend, 1995; Zarri, 1996; Zarri, 2009.
Autore scheda
Sofia Peleggi
Data creazione scheda
06.05.24
Data aggiornamento scheda
07.06.24
Revisore scheda
Serena Mauriello
Data revisione scheda
26.05.25
Stato della scheda
Compilata e da revisionare